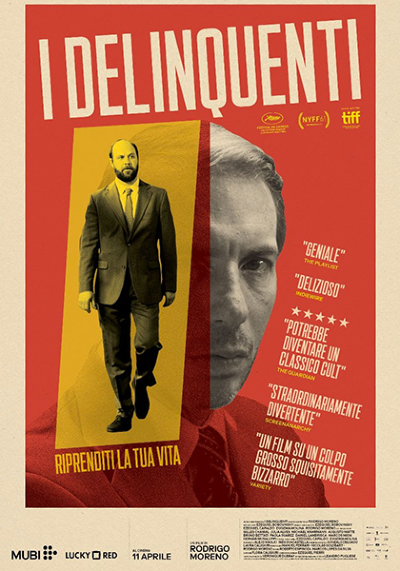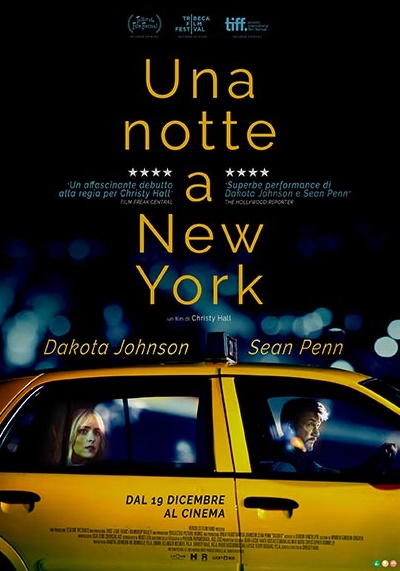Quando credi che la storia abbia finito col seppellire per sempre contesti, estetiche, tendenze ascrivibili a epoche già belle che tramontate, ecco che i corsi e i ricorsi della stessa finiscono col riesumare dall'oblio proprio quello che non avresti mai ritenuto possibile poter ripescare. È un apparente scarto rispetto al naturale evolversi del gusto e delle preferenze, che però specialmente il rock (inteso nel più ampio senso possibile) ha saputo sfruttare costantemente a suo vantaggio, ai fini del suo stesso rinnovamento. Durante lo scorso decennio è stata la new wave in tutte le sue declinazioni a essere protagonista delle più disparate reinvenzioni e re-contestualizzazioni, dopo un decennio buono di totale damnatio memoriae. Se un analogo clima di riscoperta interessa attualmente le frange più alternative del rock statunitense anni 90, in futuro, grazie all'impegno speso dai Crying nel loro full-length d'esordio “Beyond The Fleeting Gales”, un simile trattamento potrebbe essere riservato all'Aor e al rock mainstream anni 80, ormai considerati pressoché da tutti materia di culto o poco più.
Vero è che quei suoni, e le band che ne hanno fatto da tramite, hanno scritto capitoli importanti del libro del rock perché improvvisamente tutti se ne dimenticassero, tuttavia un loro “revival” sembrava alquanto improbabile, specialmente di questi tempi. Se poi a provvedere a una loro re-attualizzazione è un terzetto dedito originariamente a interpretare motivetti twee-pop sopra basi chiptune ricavate da vecchi Game Boy (!), il tutto sembra troppo surreale per essere vero. E invece Ryan Galloway, Elaiza Santos e Nick Corbo, probabilmente consci delle limitazioni di una formula comunque originalissima (ripescate l'accoppiata di Ep “Get Olde” e “Second Wind”), si spingono decisamente oltre nella propria ricerca, non soltanto riadattandosi dal punto di vista strumentale, ma soprattutto ampliando le possibilità stilistiche oltre il pensabile, fagocitando ogni stimolo o influenza con una creatività di questi tempi semplicemente straordinaria. Niente male, per una band al primo album.
Nel loro processo di trasformazione, i Crying (moniker bizzarro, considerati l'energia e il divertimento che i tre mettono nella loro musica) non hanno affatto dimenticato il proprio passato. Semplicemente hanno deciso di ripensarlo, e prendere quanto potesse essere funzionale al cambiamento: la sezione elettronica affidata ai videogiochi qui viene sostituita da sintetizzatori sfruttati con maggiore moderazione, ma al massimo del loro potenziale espressivo, e così il melodismo degli Ep, lungi dal perdere le sue qualità, le plasma alla luce delle molteplici nuove influenze dell'album, che ne manifesta tutte le possibilità inespresse.
Aor e rock anni 80 si diceva, ma il trio non si ferma qui: nell'arco dei dieci brani del disco, si passano in rassegna power-pop anni 90 (già rintracciabile negli Ep, anche se non in questa forma), spunti punk-pop, richiami glam-metal, finanche momenti in cui i Crying sembrano guardare al pop-rock giapponese contemporaneo. Un caos? Questione di punti di vista: nonostante i tre non perdano alcuna occasione per mettere in mostra la propria libertà creativa, a far da cornice ai vari brani ci pensa l'attitudine progressiva in fase di composizione, che non manca di strutturare diverse canzoni come piccole suite, e soprattutto una produzione avvolgente, pastosa, che stempera eccessi ed eventuali derive kitsch (i synth della conclusiva “The Curve”, in piena zona Europe, avevano tutto per cadere nei cliché del genere) focalizzandosi più sulle fitte trame chitarristiche di Galloway e sul coinvolgimento melodico, che già di suo ne regala parecchie di sorprese.
Se è vero che le scelte produttive talvolta sacrificano la vitalità della voce di Santos (tra le più sbarazzine frontwoman in circolazione), facendola arretrare indietro nei volumi come se si trattasse di una vocalist shoegaze, è altrettanto vero però che le stesse esaltano la profonda sinergia che anima i tre, il complesso intreccio esecutivo su cui poggiano pezzi tra i più luminosi e divertenti degli ultimi anni. “There Was A Door” parla di coming-out e libertà individuale, sviluppandosi come giocoso siparietto j-rock ricco di colpi di scena, e di una complessità sonora che non ha paura a ricorrere anche a topoi hip-hop; idealmente, non siamo poi così lontani da quanto espresso da Enon Kawatani negli ultimi anni. “Wool In The Wash”, invece, è un'incisiva presa di coscienza sulla necessità di far fronte ai propri timori, camuffata sotto un grintoso motivo power-pop, graziato da un arrangiamento tra i più ricchi dell'album e da un interessante non-ritornello.
Altrove i tre si esprimono con un linguaggio più tipicamente progressive, tra cambi ritmici memori dei Rush e linee sintetiche in continua mutazione (“Patriot”), il tempo che serve perché i Crying imprimano un'ulteriore svolta al percorso e costruiscano il più scatenato brano punk-pop della stagione, per cui molti degli eroi dell'attuale cantautorato statunitense avrebbero fatto pazzie (“Origin”). Giusto un momento per far finta di essere i nuovi Van Halen (il riff con cui attacca “Revive” pare preso di peso dalla band di Pasadena), per il resto la band non manca di tenere a freno la propria (straordinaria) esuberanza. Dapprima “cedono” all'imprinting della Run For Cover in un saggio di twee-pop accarezzato da chitarre di stampo emo (vero e proprio marchio di fabbrica dell'etichetta) e tappeti atmosferici in “Well And Spring”, successivamente propongono la loro versione di ballata glam in “Children Of The Wind”, con Santos finalmente libera di esprimersi e i synth in prima linea nel costruire il supporto musicale all'accorata linea melodica.
Oltre ogni ingessata riproposizione, spinto dal desiderio di tracciare possibili alternative future per l'indie-rock e non solo, l'esordio dei Crying è un'insperata ventata di freschezza, oltre che il più spassoso album dell'anno. Visti i tempi, concedersi un attimo di tregua è tutt'altro che un reato.
01/11/2016
Tracklist
- Premonitory Dream
- Wool In The Wash
- Patriot
- Origin
- Well And Spring
- A Sudden Gust
- There Was A Door
- Revive
- Children Of The Wind
- The Curve