Crooner di culto, scrittore pop finissimo, ma anche alfiere delle promesse mancate, Lloyd Cole è stato, per chiunque fosse adolescente e appassionato di musica indipendente negli anni Ottanta, una figura influente e determinante. La sua carriera, dopo la fortunata saga al fianco dei Commotions, è proseguita con una lunga serie di prove soliste che forse non hanno più raggiunto le vette artistiche e commerciali dei primi capolavori, ma hanno sempre lasciato trasparire l'intelligenza - e a volte, come le caso della collaborazione con Roedelius, persino la curiosità temeraria - del loro autore. Fallito l’ingresso in quel mainstream a cui lui stesso aveva consacrato un album nel 1987, l’artista del Derbyshire ha però potuto sempre contare sulla devozione sotterranea di un piccolo, ma fedelissimo drappello di fan.
Nelle spire dei serpenti a sonagli
Faccione imbronciato alla Elvis, ciuffo incluso, e fascino da letterato incompreso, Lloyd Cole è un figlio della provincia inglese: nasce a Buxton, nel Derbyshire, il 31 gennaio 1961, ma è a Glasgow, dove frequenta l'Università come studente di Filosofia, che darà una svolta alla sua vita, incontrando i futuri compagni artistici, alias The Commotions: Neil Clark (chitarra), Lawrence Donegan (basso), Blair Cowan (tastiere) e Stephen Irvine (batteria). Il gruppo si forma nel 1982 e per il debutto sulla lunga distanza dovrà attendere due anni. Il progetto, però, è già chiaro: Cole vuole congedarsi dalla new wave per virare verso un peculiare folk acustico, recuperando sonorità dei ruggenti Sixties (Byrds e Velvet Underground) e del pop-rock decadente (le ballate melodiche di David Bowie e Marc Bolan). Un’operazione che anticipa il mood preponderante nell'Inghilterra della seconda metà degli anni Ottanta e sintetizza, di fatto, tutta la formidabile scena “jangle pop” britannica di gruppi come Prefab Sprout, Aztec Camera, Deacon Blue e tanti altri. Rattlesnakes (1984) è in tutto e per tutto frutto del suo talento, che si materializza nelle sofisticate melodie, nelle citazioni letterarie dei testi (da Simon De Beauvoir a Norman Mailer), nelle interpretazioni sofferte, ma anche nei suoi modi da dandy, a metà tra Bryan Ferry e Morrissey, pur con un pizzico di sana ruralità provinciale. Pur non particolarmente dotato dal punto di vista tecnico, Cole mostra poi un grande livello di invenzione interpretativa, con un crooning atipico e una disinvoltura alla Reed. Le sue storie raccontano episodi di vita vissuta, incontri sentimentali, trasposti sul piano della memoria, con tratti di pennello impressionisti, tra malinconia diffusa e un gusto ironico che sfocia quasi nella satira.
Rattlesnakes (1984) è in tutto e per tutto frutto del suo talento, che si materializza nelle sofisticate melodie, nelle citazioni letterarie dei testi (da Simon De Beauvoir a Norman Mailer), nelle interpretazioni sofferte, ma anche nei suoi modi da dandy, a metà tra Bryan Ferry e Morrissey, pur con un pizzico di sana ruralità provinciale. Pur non particolarmente dotato dal punto di vista tecnico, Cole mostra poi un grande livello di invenzione interpretativa, con un crooning atipico e una disinvoltura alla Reed. Le sue storie raccontano episodi di vita vissuta, incontri sentimentali, trasposti sul piano della memoria, con tratti di pennello impressionisti, tra malinconia diffusa e un gusto ironico che sfocia quasi nella satira.
Ad aprire la tracklist, è l’immortale arpeggio del singolo “Perfect Skin”, un campione camuffato di new wave residuale, dalle atmosfere desolate e malinconiche. Nonostante la base prettamente folk-rock, il tutto è pervaso da una patinata glacialità decadente di fondo, che rimanda alla translucida superficie della “Be My Wife” di Bowie. Le chitarre jangle di Clark eseguono accordi fluidi e veloci, impastati con agilità, con un suono pulito e tintinnante, mentre il testo sembra quasi l’autobiografia di un promettente accademico, travolto dalle esperienze sconnesse della vita giovanile. Non è da meno il secondo singolo, la stupenda “Forest Fire”, che con le sue soffici tonalità soft-rock, appena surriscaldate dal bell’assolo finale della chitarra elettrica di Clarke, incornicia una delle melodie sopraffine cesellate dalla penna di Cole, il cui tratto si conferma delicato e intenso al tempo stesso.
A determinare il successo del disco contribuiscono anche altri due colpi da ko, piazzati rispettivamente al terzo posto della scaletta e a chiusura della seconda facciata. Il primo è la trascinante title track, uno dei capolavori assoluti del gruppo, composto da Cole insieme a Clark. Non c’è una nota di troppo, la melodia è compatta, frutto di un’intuizione illuminante. Il tutto è accompagnato da orchestrazioni rigogliose, che fioriscono nel celere minuetto dell'intermezzo, mentre le liriche, ispirate dal romanzo “Play It as It Lays” di Joan Didion, immortalano un altro personaggio femminile trasformato in archetipo universale, alludendo all’eroina del film “On The Waterfront” (“She looks like Eve Marie Saint in On The Waterfront”).
L’altro pezzo cui si accennava è “Are You Ready To Be Heartbroken?”, titolo perfetto per uno slogan sentimentale che accompagnerà per sempre la parabola di Cole. I coretti femminili sullo sfondo riecheggiano un romanticismo alla Ferry, e anche l'interpretazione di Cole lambisce i sospiri struggenti dell’ex-leader dei Roxy Music. Le chitarre acustiche si sublimano in un giro di accordi accelerato da brivido. Il brano è soffuso, dolce, etereo, ma le chitarre sono lanciate all'impazzata, con un effetto spiazzante.
Cole si rivela maestro nel saltellare da un genere all’altro, pur all’interno di una rigorosa coerenza di fondo. Ogni brano è così un piccolo saggio di metamorfosi musicale. Come “Down On Mission Street”, che parte con toni gravi e lunghe note profonde, per aprirsi nell'infantilismo giocoso del ritornello, mentre il pizzicato insistito e quegli archi sullo fondo richiamano allusivamente atmosfere orientali. O come “Speedboat”, che nasce blues scheletrico e tagliente, e si scioglie inaspettatamente in un ritornello dolcissimo e onirico, che sembra stralciato dalla migliore produzione degli Smiths, l’altra band che seppellì il punk a suon di strimpellii sixties. Il jangle-pop resta la tela, ma le tinte possono colorarsi di suggestioni francesi (il crepuscolare valzer di fisarmoniche di “Charlotte Street”, altra prodezza melodica e altra figura femminile memorabile), di scanzonate andature folk’n’roll (“Four Flights Up”, con il suo rush energetico di chitarre accompagnate da delicati synth sullo sfondo), di orchestrazioni easy listening (il bozzetto pop di “Patience”, adorabile anche nei suoi coretti kitsch iniziali e nelle sue orchestrazioni patinate, figlie dell’epoca), e di atmosfere bucoliche di stampo beatlesiano, come su “2cv”, sorta di “Blackbird” à-la Cole, con un gioco di accordi di chitarre che dà l’impressione che esse procedano a tratti "a ritroso" e un testo che fa i conti con il disincanto per un'aspettativa sentimentale delusa, nel cuore di una torrida estate londinese.
Rattlesnakes ottiene un'accoglienza piuttosto contrastata: la scalata alla classifica inglese si fermerà al n. 13, tuttavia l’album riuscirà a superare le 100.000 copie vendute, assicurandosi un disco d'oro. L'accoglienza più importante, però, verrà da critica e colleghi: l’influente rivista musicale Nme lo inserirà addirittura nella lista dei 100 migliori album di tutti i tempi. E non mancheranno gli omaggi di altri artisti, tra i quali i Manic Street Preachers, che lo annovereranno tra i loro dieci dischi preferiti di sempre, e Tori Amos, che gli riconoscerà un importante tributo con la cover di “Rattlesnakes”. Sicuramente è uno dei dischi che coglie appieno lo spirito di quegli anni, sospesi tra il crepuscolo dell’era wave e l’esplosione del nuovo (indie)pop.
Dieci pezzi facili Per l’atto secondo Easy Pieces (1985), ispirato proprio al film “Five Easy Pieces” di Bob Rafelson, Cole leviga ulteriormente la superficie del suo suono, tra violini, ottoni e tastiere patinate, ma le melodie cominciano a farsi più scialbe, e talvolta si ha il sospetto che l’artista inglese si lanci nell'improvvisazione delle strofe basandosi su semplici giri di accordi, con il suo talento per i ritornelli a salvare in più di un caso la situazione (si veda ad esempio "Rich" e "Grace"). Fa eccezione un piccolo gioiello di nome "Cut Me Down", con il suo pacato slancio emotivo e un ritornello perfetto, nel solco di quel pop britannico 80 del lustro immediatamente successivo (da lì a poco, ad esempio, sarebbero usciti fuori i Deacon Blue di “Dignity”.)
Per l’atto secondo Easy Pieces (1985), ispirato proprio al film “Five Easy Pieces” di Bob Rafelson, Cole leviga ulteriormente la superficie del suo suono, tra violini, ottoni e tastiere patinate, ma le melodie cominciano a farsi più scialbe, e talvolta si ha il sospetto che l’artista inglese si lanci nell'improvvisazione delle strofe basandosi su semplici giri di accordi, con il suo talento per i ritornelli a salvare in più di un caso la situazione (si veda ad esempio "Rich" e "Grace"). Fa eccezione un piccolo gioiello di nome "Cut Me Down", con il suo pacato slancio emotivo e un ritornello perfetto, nel solco di quel pop britannico 80 del lustro immediatamente successivo (da lì a poco, ad esempio, sarebbero usciti fuori i Deacon Blue di “Dignity”.)
In generale, però, Cole sembra più a suo agio quando si riaggrappa alla sua matrice folk, ravvivando le composizioni con idee piuttosto felici, come accade in "Pretty Gone", o ancor meglio di "Her Last Fling".
Anche le interpretazioni perdono un po’ di mordente. Se in Rattlesnakes Cole aveva sperimentato varie modalità di espressione, ora ne sceglie una e la mantiene costante in tutto l'album: ci riferiamo a quella voce gracchiante e strozzata che se da un lato ne è diventata un tratto caratterizzante e distintivo, dall'altro alla lunga può stancare.
Oltre al pop, Easy Pieces si apre al soul, ma le due cose nell'Inghilterra di quegli anni non erano poi così disgiunte. Lo si vede subito nel brano di apertura, "Rich", con quegli ottoni che ci ricordano un po' il Reed di "Berlin" (“Oh Jim”, “How Do You Think It Feels”), anche se sopravvivono vaghe sensazioni smithsiane nel bel ritornello. Ancora un refrain azzeccato in "Pretty Gone", che nella parte finale riprende gli ottoni soul di “Rich”. "Grace" è probabilmente uno dei brani meglio riusciti: tornano le fisarmoniche e le atmosfere malinconiche parigine nebbiose di “Charlotte Street”, ma la melodia e il ritmo sono più incalzanti; funziona anche il ritornello, che si inserisce come una pausa di riflessione inaspettata, con venature di cupezza. "Lost Weekend" è quasi una versione "folk" della “The Passenger” di Iggy Pop, ma il suo impeto viene subito bilanciato da quella specie di "Are You Ready To Be Heartbroken?" portata all'immobilismo che è “James”.
E se il pop melanconico e zuccheroso di “Perfect Blue”, con una certa dose di clemenza, si può far ancora passare come episodio emblematico di un’epoca, "Brand New Friend" eccede davvero in leziosismi, con la sua scansione ritmica a base di orchestrazioni sintetiche dance e vezzosi coretti a corredo, nel solco di quel “pop-soul made in Uk” che stava esplodendo in quegli anni, con i Simply Red come capofila.
Alcune versioni dell’album contengono tracce originariamente uscite come B-side. Su tutte svetta "Her Last Fling", con l’illusorio crescendo armonico ed emotivo delle sue magnifiche tastiere organistiche spalmate su agili e ritmiche chitarre acustiche: inspiegabile la sua assenza dalla tracklist, sarà però recuperata nel futuro “Best of”.Da segnalare anche "Minor Character", dall'andamento armonico, melodico e strumentale che arriva quasi a citare il beat, più superflua "Big World", con il suo citazionismo rock, in bilico tra Elvis Presley e Chuck Berry.
Diversamente dallo storico predecessore, Easy Pieces riuscirà a entrare nella classifica inglese direttamente al n. 5. Ma forse c'è dell'altro: a un anno di distanza i tempi erano già più maturi per una miglior ricezione dell'offerta musicale della band, in un'Inghilterra che era ormai uscita da certi canoni synth-wave e si proiettava verso nuove sonorità.
Un tuffo nel Mainstream Nonostante il successo commerciale, però, Easy Pieces non soddisfa il gruppo. Lloyd Cole ammetterà come questo secondo lavoro avesse “smarrito la freschezza dell’esordio, senza rimpiazzarla con qualcos’altro”, mentre Donegan arriverà addirittura a definirlo “terribile”. Fatto sta che il successivo Mainstream (1987) segna un parziale cambiamento di rotta.
Nonostante il successo commerciale, però, Easy Pieces non soddisfa il gruppo. Lloyd Cole ammetterà come questo secondo lavoro avesse “smarrito la freschezza dell’esordio, senza rimpiazzarla con qualcos’altro”, mentre Donegan arriverà addirittura a definirlo “terribile”. Fatto sta che il successivo Mainstream (1987) segna un parziale cambiamento di rotta.
Per certi versi, la band con questo lavoro tenta di entrare davvero nel "mainstream" musicale e discografico. E ciò significa, anzitutto, uscire finalmente allo scoperto, con un pizzico di divismo in più. Il dandy Cole, dall'alto della sua altezzosità intellettuale, era rimasto negli artwork dei lavori precedenti ostentatamente “in ombra”. Ora passa invece al chiaro-scuro d'autore: il fotografo Alastair Thain accorre a immortalare uno dietro l'altro Cole e compagni in una serie di primi piani patinati con cui corredare il booklet dell’album. E sul piano musicale perché non ricorrere finalmente, come tutti, al meglio della produzione a cui si può attingere? La nuova impresa non si rivela però così facile, e dopo un primo tentativo con Stewart Copeland dei Police, la scelta definitiva cade su Ian Stanley, uno dei due membri nascosti dei Tears For Fears e transfuga dalla band dopo i fasti di "Songs From The Big Chair" (album che con il suo successo planetario aveva in effetti ben caratterizzato il mainstream degli anni 80).
L'operazione alla fine riesce, almeno in parte, giacché il salto in avanti nella produzione si sente eccome e l'album riporta la formazione nella Top 10 degli album più venduti in Gran Bretagna. E se il genio appare forse un po’ sbiadito, si può sempre ben contare sul rodato paracadute del mestiere. Come nell’efficace apertura, affidata a “My Bag”: un riuscitissimo esemplare di funky bianco da far invidia a tutti quelli che ci hanno "provato", vedi i vari Curiosity Killed The Cat e compagnia. È un inizio incalzante che si pone come successore credibile di "Perfect Skin", con un bel basso pulsante sullo sfondo e un convincente inserimento di chitarre squillanti sul ritornello. Cole gioca di nuovo col fuoco per quanto riguarda il pop ("From The Hip" e "Hey Rusty"), ma per fortuna questa volta in modo meno stucchevole, e gli va particolarmente bene con "29" (niente da fare: coi ritornelli ci sapeva fare), stilisticamente piuttosto indecifrabile e tra gli episodi di maggior interesse del disco.
Quando si arriva alla title track, ci si rende conto che in realtà è uno degli elementi meno "mainstream" dell'intero lavoro, con il suo folk così silenzioso e appena sussurrato (ma con un finale di chitarre sontuoso e al contempo sobrio che funge da cassa armonica ad amplificare il suono minimale del resto del brano). Persuade anche, nonostante la sua impostazione convenzionale, "Mister Malcontent", in particolare nel finale, che ha la monumentalità vocale e strumentale dei Simple Minds e le chitarre bowiane di "Look Back In Anger".
Cole, soprattutto, sa ancora pennellare melodie memorabili, come nella leggiadra ballata di "Jennifer She Said" per chitarre, archi e (soffuse) tastiere; l’ennesima prodezza pop e capolavoro del disco, con tanto di echi "morrisseyani" nella variazione che segue il ritornello. Una menzione a parte va a "Big Snake", opera di un Cole che fa i conti con le proprie morbosità affettive e cede, per l’unica volta nel disco, la firma delle musiche al produttore Ian Stanley. Grazie a lui, recuperiamo in questo pezzo ciò che mancava ancora di fondamentale del panorama britannico di quegli anni, il jazz soffuso e notturno di Sade: splendido, in particolare, il breve intermezzo di tromba strozzata che ferisce dolorosamente il brano.
C’è poi la curiosità di "Sean Penn Blues": si tratta forse del primo tributo, a dire il vero non troppo lusinghiero, a colui che in quell'epoca, ben lontano dai due Oscar guadagnati in seguito e dal divenire uno dei nomi di punta di Hollywood, non era ancora altro che "Mister Madonna", come Cole stesso lo denomina. Ambiguo il finale di "These Days" (nulla a che vedere con il brano omonimo dei Joy Division), caratterizzato dalla contrapposizione tra la filastrocca delle strofe poggiata sul clavicembalo e l’improvviso incupirsi del ritornello, sofferto e crepuscolare.
La storia della gloriosa ditta Lloyd Cole And The Commotions si chiude praticamente qui, ma non quella del suo “titolare”. Era naturale che il (quasi) “one-man-band” della formazione facesse cadere l’“and” e ciò che lo seguiva per intraprendere una lunga carriera solista (per lo meno sul piano formale, in verità più volte ancora affiancato da Clark e Cowan). I titoli di coda saranno, come da consuetudine, la pubblicazione di un immancabile “Best of” (1984-1989) e un’irrinunciabile reunion molti anni più tardi, nel 2004, per festeggiare il ventennale dell’uscita di Rattlesnakes.
Englishman in New York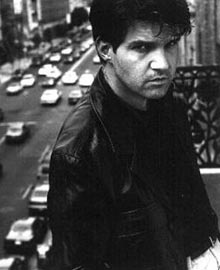 La caduta ufficiale della congiunzione "and" viene sancita dall'uscita del primo album solista del 1990, denominato appunto, quasi con orgoglio, Lloyd Cole, titolo che ribadisce l’intenzione di prendere in mano la propria carriera, ma anche una sostanziale continuità. Quello a cui assisteremo nel corso della lunga carriera solista è tuttavia lo sviluppo di un Cole sempre più intimista, come autore e come interprete. Curiosamente, sarà soprattutto il pubblico svedese ad apprezzare la sua proposta, regalandogli più volte l’ingresso nella top ten degli album più venduti.
La caduta ufficiale della congiunzione "and" viene sancita dall'uscita del primo album solista del 1990, denominato appunto, quasi con orgoglio, Lloyd Cole, titolo che ribadisce l’intenzione di prendere in mano la propria carriera, ma anche una sostanziale continuità. Quello a cui assisteremo nel corso della lunga carriera solista è tuttavia lo sviluppo di un Cole sempre più intimista, come autore e come interprete. Curiosamente, sarà soprattutto il pubblico svedese ad apprezzare la sua proposta, regalandogli più volte l’ingresso nella top ten degli album più venduti.
Trasferitosi a New York e ingaggiato un team d'eccezione, formato da Robert Quine alla chitarra, già nei Voidoids di Richard Hell, così come Fred Maher (ex-Material) alla batteria, più Matthew Sweet, futura star del power pop al basso, Lloyd Cole si reinventa nei panni raffinati di un songwriter decadente post-wave, mostrando di poter avere un futuro anche senza la sua storica backing band.
È la tensione chitarristica sottopelle di Quine ad animare numeri come la sofferta "Don't Look Back" e la vibrante "No Blue Skies"; mentre la vena più malinconica e desolata di Cole riemerge su ballate di razza, come "Undressed" – dove si cala nei panni del narratore erotico - e "To The Church", in cui riaffiora anche il suo gusto mordace tipicamente British.
In generale, domina un suono più duro e diretto, rispetto all’esperienza dei Commotions, che si rispecchia in omaggi nascosti ad amati glam-rocker come Bolan ("Sweetheart") e in interpretazioni più secche e dirette. Cole invita senza troppi fronzoli la sua amante a "trovare al suo corpo qualcun altro e strappare le stelle dal cielo" ("No Blue Skies") e snocciola nuove torbide avventure amorose (“Ice Cream Girl”, “Loveless”), senza rinunciare per questo alle sue contrite riflessioni esistenziali (“Don't Look Back”).
Lloyd Cole, insomma, segna a tutti gli effetti l’inizio di una seconda vita per il crooner del Derbyshire, particolarmente stimolato dalla nuova avventura americana e dalle suggestioni musicali che gli porta in dote.
La seconda prova solista, Don’t Get Weird On Me Baby del 1991, è un album diviso in due parti (e in un certo senso in tre). La prima, la migliore, si presenta come il concerto per "sussurri e orchestra" di un autore che schiude in modo pudico e intimista il proprio cuore. Un autore che, a dire il vero, non ha perso il gusto per il pop, ma che, lasciando libera la propria emotività senza indossare alcuna maschera, non cede a seduzioni stucchevoli. Questa prima parte si apre in modo felice con "Butterfly", ricca di orchestrazioni melodrammatiche a creare l’effetto di una colonna sonora alla John Barry. Il trip-hop di Bristol bussava già alle porte, ma "Butterfly" costituisce piuttosto un campione perfetto di musica pop. I suoi toni, comunque sostenuti, si stemperano subito nella leggerezza di "There For Her", dove agli immancabili archi si sovrappone un’armonica, in un accostamento quantomai inconsueto. Viene poi il Burt Bacharach riletto di "Margo’s Waltz", mentre "Half Of Everything" riprende i toni più tesi di "Butterfly" e ci dona il meglio del Cole interprete. Chiudono il cerchio la felpata "Man Enough", memore degli Steely Dan, e "What He Doesn’t Know", poco più di un sussurro, con quell’accordo di chitarra ripetuto indefinitamente che ne fa un po’ la “House Of Cards” dei Radiohead in versione Cole.
Per intuito melodico e capacità di sintesi, la prima parte poteva costituire un lavoro a sé e uno degli episodi più felici della produzione solista di Cole. Poi però giunge "Tell Your Sister" a rompere improvvisamente con quanto ascoltato finora, introducendoci nella seconda parte con un’energia in bilico tra la “My Bag” registrata insieme ai suoi vecchi compagni e i Simple Minds di "Once Upon A Time" (anche nella voce, che riecheggia lo stile di Kerr). La parentesi rock prosegue con "Weeping Wine" e "To The Lions", mentre quella che è l'ideale terza parte del lavoro, una sorta di fusione stilistica delle prime due, consiste nelle ultime tre tracce e termina con un finale ad effetto che altrove sarebbe stato proposto come traccia di apertura: "She’s A Girl And I Am A Man"; quale brano meglio di questo potrebbe interpretare la quintessenza dell’easy listening anglosassone?
Vibrazioni negative Il successivo Bad Vibes è nel complesso più solidamente ancorato alle chitarre e alla forma rock rispetto all’album precedente e vanta un bell’inizio con "Morning Is Broken", gioco di parole dalla “Morning Has Broken” di Cat Stevens: un brano pop dalle chitarre sontuose che riporta alla mente i Silencers dell’epoca di “Letters From St. Paul”. La successiva “So You’d Like To Save The World” è una canzone inclassificabile, ironica, con distorte chitarre di sapore hawaiano e commenti corali improbabili. Tutto sommato questo Cole solista ci sembra però meno impostato, e quindi più vero, di quello degli ultimi album con il suo gruppo storico. I brani che seguono dicono infatti la loro opinione in modo onesto e sincero, da "Holier Than You", a "Love You So What".
Il successivo Bad Vibes è nel complesso più solidamente ancorato alle chitarre e alla forma rock rispetto all’album precedente e vanta un bell’inizio con "Morning Is Broken", gioco di parole dalla “Morning Has Broken” di Cat Stevens: un brano pop dalle chitarre sontuose che riporta alla mente i Silencers dell’epoca di “Letters From St. Paul”. La successiva “So You’d Like To Save The World” è una canzone inclassificabile, ironica, con distorte chitarre di sapore hawaiano e commenti corali improbabili. Tutto sommato questo Cole solista ci sembra però meno impostato, e quindi più vero, di quello degli ultimi album con il suo gruppo storico. I brani che seguono dicono infatti la loro opinione in modo onesto e sincero, da "Holier Than You", a "Love You So What".
Anche la parentesi blues sussurrata di "Wild Mushrooms" non suona del tutto scontata come rischierebbe di essere, mentre "My Way To You" ci dona un musicista britannico in piena influenza americana e in "Too Much Of A Good Thing" si scivola nuovamente nel pop fluido alla Deacon Blue. Ma l’episodio pop più felice (se proprio vogliamo classificarlo così) è quello di “Mister Wrong”, raffinata e accattivante al punto giusto. Bene anche il rock singhiozzante di "Fall Together”, quasi una citazione della quasi omonima e più celebre “Come Together” dei Beatles.
Bad Vibes, nel complesso, non sfonderà, fermandosi al n.38 della Uk chart (ma non nell’imprevedibile Svezia, dove salirà fino al n.8).
L'apertura di Love Story, quarto album solista, targato 1995, rivela subito un'ulteriore virata di gusto, questa volta in direzione delle chitarre acustiche, che ci riportano per certi versi ai tempi di Rattlesnakes. Ben riuscito l’ambiguo ritornello della prima traccia "Trigger Happy", quasi una rilettura della vecchia “2cv”. Interessante anche "I Didn’t Know That You Cared", con le sue ampie e aeree orchestrazioni di sottofondo. Il carillon di “Baby” si pone a suo modo con due anni di anticipo rispetto a “No Surprises” dei Radiohead, mentre “Unhappy Song”, accostabile più a “Are You Ready To Be Hearbroken” che a “2cv”, è una ballata folk sullo scorrere dei mesi.
Ci piace ricordare ancora gli accordi acustici sconnessi di “Let’s Get Lost”, che comportano inoltre, come un ascolto accorto può ben rivelare, una certa dote di virtuosismo vocale, non ostentato eppure presente nell'inseguimento di un’armonia così volutamente stonante nelle strofe.
Negli anni 1997-1998 Cole fonda con alcuni giovani musicisti newyorkesi (Jill Sobule, Dave Derby, Mike Kotch, Rafa Maciejak) i Negatives. Il risultato di questa unione è l’album omonimo del 2000.
Nonostante l’apporto statunitense, si tratta ancora di un album decisamente britannico, che non si discosta dall'ormai usuale stile intimista del Cole solitario. Al contempo, l'aggiunta di nuove forze non sembra giovare molto al livello compositivo del lavoro: nel complesso si avverte un certo appiattimento melodico e una povertà di idee nell’ideare e confezionare i brani. L’impressione è che l’intimismo tenda a stemperarsi eccessivamente in agrodolce. Non mancano tuttavia piccoli sussulti, come l’adrenalinica "Tried To Rock", che riporta a certi suoni del debutto solista, alzando le pulsazioni all’insegna di un bel rock metropolitano, o la melodiosa "What's Wrong With This Picture", che scatta nuove istantanee sentimentali sopra luminosi accordi di chitarra (“'Smile', she said, and if you want/ I'll look the other way/ Until you regain your melancholy disposition/ Or until you get over yourself”).
Appagato nella sua nuova dimensione solista e newyorkese, a 40 anni Cole si concede il lusso di citarsi addosso, con l’iniziale “Past Imperfect”, che semina riferimenti alle vecchie "Brand New Friend" e "Lost Weekend".
Germi elettronici Accantonata l’esperienza dei Negatives, Cole torna alla sua veste solista con Plastic Wood (1995), che esce a sei anni di distanza dal precedente Love Story e gioca a sorpresa una mossa del tutto inaspettata. Si tratta infatti di un album completamente strumentale, costituito da dilatate atmosfere elettro-ambientali.
Accantonata l’esperienza dei Negatives, Cole torna alla sua veste solista con Plastic Wood (1995), che esce a sei anni di distanza dal precedente Love Story e gioca a sorpresa una mossa del tutto inaspettata. Si tratta infatti di un album completamente strumentale, costituito da dilatate atmosfere elettro-ambientali.
Cole non si era mai allontanato dalla forma-canzone, né tantomeno aveva mostrato un interesse così marcato verso le sonorità elettroniche, inseguendo sempre piuttosto, con sapiente intuito, modelli del tutto rodati (in particolare pop, rock, soul e folk). Per certi versi persiste comunque il gusto per il minimalismo, tipico della sua produzione solista, e il risultato finale suona suggestivo e stimolante.
Le tracce dove si osa di più sono quelle di chiusura: la trance ipnotica di "Park West", il quasi-industrial angoscioso di "Post Script", e la rivisitazione in chiave jungle della "Trans-Europe Express" dei Kraftwerk in "Machinist".
Nello stesso anno viene rilasciata anche una compilation di outtake, Etc, ma qui si tratta del Cole che conosciamo, questa volta alle prese con una serie di ballate acustiche d’autore. Un Cole che nella sovrapposizione chitarre-fisarmoniche guarda dritto al maestro Bob Dylan.
Il nuovo millennio si apre con un altro lavoro solista, Music In A Foreign Language (2003). L’avvio, affidato alla malinconica title track, appare sia dal punto di vista melodico che interpretativo una delle migliori prove del Cole post-Commotions. Molto riuscita anche la successiva “My Other Life”, nel perfetto climax ottenuto tra tensione e delicatezza, con quel pianoforte struggente in stile Nick Cave. E proprio dal bardo di Melbourne Cole prende in prestito “People Ain’t No Good”, per una cover intensa e sentita.
Purtroppo, però, il resto dell’album non si mantiene su questi standard, adagiandosi su un ormai troppo abituale già sentito, nonostante l’indubbia classe degli arrangiamenti minimali, densi di malinconia, dove all’impianto voce-chitarra acustica si affiancano qualche sparuta tastiera e un lieve tappeto di percussioni.
Lloyd Cole non è più il giovane artista colto, dalla voce affascinante e dallo sguardo ironico che scriveva capolavori senza tempo come "Forest Fire", "Perfect Skin" e "Jennifer, She Said". Si è smarrito. Ogni tanto è riemerso, per poi perdersi nuovamente in una offerta musicale che non ha più, per i fruitori attuali, il fascino e l’appeal di una volta. Anche se la classe, a tratti, riesce a risplendere ancora.
"Hey Lloyd I’m Ready To Be Heartbroken" Nel frattempo, però, al dandy di Buxton giungono nuovi, sentiti omaggi. Come quello di una delle migliori band indie-pop in circolazione, i Camera Oscura, che intitola un proprio singolo "Hey Lloyd I’m Ready To Be Heartbroken", in risposta alla celebre "Are You Ready To Be Heartbroken?", incisa nel lontano 1985. Cole incassa e prosegue a testa bassa, con la consapevolezza di essere uno dei grandi antesignani del nuovo pop "da cameretta" e l’ostinazione di chi non è più disposto a scendere a compromessi.
Nel frattempo, però, al dandy di Buxton giungono nuovi, sentiti omaggi. Come quello di una delle migliori band indie-pop in circolazione, i Camera Oscura, che intitola un proprio singolo "Hey Lloyd I’m Ready To Be Heartbroken", in risposta alla celebre "Are You Ready To Be Heartbroken?", incisa nel lontano 1985. Cole incassa e prosegue a testa bassa, con la consapevolezza di essere uno dei grandi antesignani del nuovo pop "da cameretta" e l’ostinazione di chi non è più disposto a scendere a compromessi.
Celando forse nel titolo una riflessione sarcastica sulla propria carriera, Antidepressant (2006) sforna undici brani di rock leggero e introspettivo, caratterizzati per lo più da una vena malinconica e meditabonda.
I suoni che permeano il lavoro sono di chiara matrice pop, caratterizzati da una produzione e da arrangiamenti piuttosto convenzionali e mainstream, arricchiti da un’orchestrazione molto presente, ma discreta e mai troppo invadente. Qualche brano è più ritmato e solare, ma il mood del disco è dettato da tempi dilatati e soffusi, da chitarre slide, armonica, spazzole e tutta quella strumentazione che ci si aspetta di trovare in un album di raffinate canzoni pop-rock fortemente venate di folk e country. L’insieme dà l’idea di un mix tra momenti tristi e malinconici e situazioni più luminose e felici. Ma, per dirla con le parole di Lloyd, "un antidepressivo è una pillola che si prende e che ti fa stare bene, ma il prenderlo implica l’esistenza della depressione".
Torna il gusto per la descrizione di personaggi lirico-surreali che aveva dato i suoi frutti eccezionali in Rattlesnakes. Ecco quindi "The Young Idealist", che con il suo incedere rilassato ci riporta indietro ai tempi delle situazioni filosofico-accademiche descritte nell’album d’esordio, raccontando storie ordinarie di sogni infranti e di cinismo di ritorno con eleganti giochi di parole e riferimenti culturali non scontati, senza però sfociare nel pessimismo e nella disperazione. La scanzonata e beatlesiana "Woman In A Bar", invece, rimanda alle fantastiche figure femminili descritte in quell'epoca, segnando uno dei momenti più luminosi dell’album, insieme a "New York City Sunshine" e alla title track, episodi in cui i testi di Cole si fanno più ironici e meno sarcastici, e anche l’accompagnamento è più ritmato e corposo, con l’inserimento di tastiere e archi.
In pezzi come "I Didn’t See It Coming", Cole ironizza sulla propria incapacità di fare la mossa giusta, mentre nella intimista "How Wrong Can You Be?" una raffinata chitarra acustica introduce una ballata di classico stampo folk-rock, che racconta l’ennesima storia di una relazione finita male.
È però il finale dell’album, dopo qualche brano meno riuscito, a regalarci le vere gemme della raccolta: anzitutto "Travelling Light", ballata "alla Commotions", nel cui incedere cadenzato il pop sposa felicemente il country. E, per finire, "Rolodex Incident" che, dopo un malinconico passaggio strumentale di circa due minuti, riporta Lloyd, con la sua voce inconfondibile, nella veste del cantore dei "cuori infranti", dipingendo un quadro di amori perduti e rimorsi.
I timidi segnali di riscossa di Antidepressant si spengono però quattro anni dopo in Broken Record (nomen omen, ahinoi...), lavoro decisamente fiacco e insapore.
Dopo la raccolta quadrupla di B-side e rarità edita nel 2009, Cleaning Out The Ashtrays, rimpolpata nello stesso anno dalla pubblicazione di un paio di dischi dal vivo registrati a Dublino e Brema, il nostro ha pensato di smuovere un po’ le acque dando alle stampe un lavoro che in definitiva si lascia ricordare quasi solo per le illustri collaborazioni: si va infatti da Joan As Police Woman, passando per i vecchi amici Fred Maher, Dave Derby (già al fianco di Cole nei Negatives) e dell’ex-Commotions Blair Cowan.
Il songwriter inglese, da diversi anni stabilmente trapiantato negli Stati Uniti, al pari di un Elvis Costello riveduto e corretto alla luce di un pacato understatement signorile da intellettuale in esilio, sembra aver trovato un proprio equilibrio stilistico nella dizione pulita e lineare di un folk-pop medio e sin troppo confidenziale, infarcito di stereotipi blandamente americani ai limiti della più pallida stucchevolezza manieristica, che lasciano perplessi. A latitare sono soprattutto valide canzoni in cui sia possibile rintracciare la flebile ombra di quel raffinato, colto e sensibile crooner generazionale degli Eighties, in bilico tra Morrissey, Scott Walker, Roy Orbison e Burt Bacharach.
Broken Record offre la grafia lievemente nostalgica e crepuscolare di piccole cartoline country-folk gualcite, nelle quali a dominare è la mezzatinta sbiadita di una vena compositiva prevedibile, che diluisce il proprio indebolimento senile nel tono controllato e gentile di piccole ovvietà musicali. A salvarsi sono alcuni modesti episodi come “Oh Geneviève”, “Double Happiness”, “Writers Retreat” o “That’s All Right”, in cui traspare ancora, come un lampo fuggevole, qualche sprazzo vitale di quel piccolo grande interprete dell’indie-pop inglese.
Nel 2013 Cole ci prova ancora. Stavolta, però, lo stimolo decisivo per tentare di rinvigorirsi ha un nome e un cognome in Bob Dylan e uno specifico riferimento nell’album “Tempest”, accolto con entusiasmo dall’ex-frontman dei Commotions.
Seguendo il modello di Dylan, il cantautore inglese fa dietrofront, riappropriandosi del suo passato più glorioso e sciorinando in Standards (2013) una manciata di tirate elettriche reediane con cui si trova evidentemente più a suo agio rispetto alla mise da folksinger nostalgico che ne aveva indebolito la produzione più recente. Non è un caso che proprio il nome di Reed sia il primo a venire in mente qui, dove il consueto understatement delle liriche si muove in un contesto sonoro debitore di quella New York che fu sì luogo dove ebbe inizio la carriera solista di Cole, ma soprattutto regno musicale dell’ex-Velvet Underground, tant’è che ancor più decisiva risulta oggi la presenza dietro i tamburi del fido Maher, al secolo produttore proprio di “New York” di Mr. Reed. Accanto a lui, figurano tra i guest compagni di viaggio ormai consolidati come la “policewoman” Joan Wasser e il tastierista ex-Commotions Blair Cowan, mentre alla chitarra di Lloyd risponde quella del figlio, Will. Su queste basi viene messa in piedi un’autentica fiera del citazionismo, anche se la riproposizione di certi “standard” è resa meno pedissequa grazie a un Cole ritornato in grande spolvero come melodista.
Apre le danze una “California Earthquakes”, cover di John Hartford, che sa di rito di passaggio dal country-folk del legittimo proprietario al rock'n'roll stradaiolo in cui viene immersa. Va poi ancora meglio con “Women’s Studies”, primo pezzo autografo del lotto, sui cui riff spigolosi si ergono in perfetto equilibrio ironia testuale (“To complete my education I had to wake up in your bathtub”) e ispirazione melodica a presa rapida. Quasi tutto l’album è comunque un continuo susseguirsi di hook contagiosi e incisive digressioni intimiste, avvalorate anche dal crooning di Cole, capace di evocare ora i languori di Chris Isaak (“Blue Like Mars”), ora il nervosismo latente di Elvis Costello (“Period Peace”). Dato il senso di leggerezza infuso dal distacco intellettuale delle liriche, i brani tirati colpiscono più trasversalmente che come pugni in faccia, mentre le ballate ritornano alle vecchie seduzioni alt-country, ritagliandosi un ruolo degno di nota come pause di riflessione (le Tweedy-iane “Myrtle And Rose” e “No Truck”, poggiate su un minimalismo chitarristico di grande profondità).
Tra i pochi momenti morti, va segnalata invece “Opposite Days” che, coi suoi riff in botta e risposta, finisce per diventare un requiem fin troppo passatista agli anni d’oro del Cbgb. Si tratta comunque di una parentesi poco determinante in un percorso che prosegue senza intoppi fino al decisivo uno-due finale in cui si condensa tutto il Cole del 2013, tra melodie sophisti-pop di purezza cristallina (“Kids Today”) e tributi pagati con onore alla periferia americana (“Diminished Ex”, di chiara calligrafia Whiskeytown, ma con una concretezza quasi tridimensionale nelle sovraincisioni di chitarre che non può lasciare indifferenti).
Un Cluster impazzito Poi, nel 2013, arriva la collaborazione che non t'aspetti.
Poi, nel 2013, arriva la collaborazione che non t'aspetti.
Lloyd Cole è sempre stato un fan dei Cluster, in particolare dell’album del 1976 “Sowiesoso”, e le tinte elettroniche del suo Plastic Wood del 2001 recavano più di un segno di questa predilezione. Proprio quel lavoro era piaciuto molto a Roedelius, che dei Cluster fu cofondatore assieme a Dieter Moebius, al punto che il compositore tedesco aveva manifestato il desiderio di poter lavorare con Cole a un progetto comune. Obiettivo perseguito realmente a partire dal 2011, quando finalmente i due si sono incontrati a Vienna, iniziando a gettare le basi per l’album a doppia firma che sarebbe arrivato due anni dopo.
Selected Studies Vol.1 (2013) rivela una musica matura, composta con cura meticolosa, in cui però le sonorità elettroniche si condensano in episodi semplici e diretti. Cole non canta e nemmeno suona la chitarra, mentre Roedelius tocca raramente i tasti del suo pianoforte. I due musicisti si concentrano soprattutto nel tessere sottili scenari sonori, oscillando tra momenti rilassati di grande suggestione (“Virginie L”, “Lullerby” e “Still Life With Kannyu”) tra effetti di piano arricchiti da vigorose melodie kraut-rock ed echi di Satie e Debussy, e slanci ritmici propulsi da tastiere sbilenche in stile Cluster (“Fehmarn F/O”), con sporadiche derive verso il noise (“Wandelbar”, “HIQS”).
Un matrimonio riuscito, insomma, quello tra il sophisti-pop britannico e l'avanguardia elettronica tedesca, per un esperimento che potrebbe restare un curioso unicum nella carriera del cantautore britannico.
Quasi al traguardo dei sessanta, Cole torna con un coup de théâtre. Radunando nel tuo attico mansardato in Massachusetts parte della gloriosa truppa che fu (Neil Clark alla chitarra e Blain Cowan ai synth, ovvero 3/4 di Commotions che non registravano insieme dal 1987). Ne scaturisce Guesswork (2019), un disco di pura sintesi elettronica. A volte lento e misurato, a volte più ritmato, ma sempre con la classe e il piglio dei giorni migliori.
Già l’iniziale “The Over Under” spazza via le nubi e illumina di immenso. Sette minuti di poesia musicata, eterea, rallentata, una melodia efficacissima che si snoda tra note minime di piano ed effetti ambientali lontani. Una voce più profonda, appesantita dagli anni, ma per questo ancora più efficace. La successiva “Night Sweats” cambia parzialmente registro. E’ l’episodio più classicamente synth-pop del lotto, quello che più di tutti contiene i dettami che hanno reso celebre il movimento: intro minimale con singole note di synth, base robotica sorretta da drum machine e basso pulsante, e classico riff sintetico che poi è il vero marchio identificativo del genere. Un cantato accorato, quasi invettivo e "motherfucker" come se piovesse. Ci si addolcisce appena nel ritornello, prima del pirotecnico finale.
Più leggera ma ugualmente efficace, e anzi per assolvere il compito di singolo decisamente più efficace, “Violins”, riuscito mix tra l’Erlend Oye solista e gli Erasure attuali. Tutto il disco è un riuscito alternarsi di brani midtempo e ballad assassine, di archi sintetici e delicati passaggi al piano, un’atmosfera crepuscolare e malinconica palpabile in ogni solco. Esemplare in questo senso “Remains", gioiello di improbabile e disarmante dolcezza e vetta indiscussa dell’album. In altri passaggi invece l’incedere è più scarno, minimale, accompagnato da suoni sintetici glaciali e percussioni elettroniche che ne completano l'arrangiamento. Quello che colpisce è la qualità media delle canzoni, sempre ben sopra la sufficienza. Clamoroso, ad esempio, il ritornello di “When I Came Down From The Mountain", che si apre in una melodia esaltata da tappeti di synth e chirurgici interventi di chitarra elettrica a suggellare un intreccio sonoro di enorme impatto emotivo. E si chiude, e non è una coincidenza, con rimandi totalmente à-la Kraftwerk di “Autobhan" nell'incipit di "Loudness War".
On Pain (2023) è un’altra dolente raccolta di canzoni, questa volta adagiate su strati di sonorità di synth, abilmente stemperate dall’apporto di due vecchi compagni d’avventura (gli ex-Commotions Blair Cowan e Neil Clark) e da nuove, preziose conoscenze coltivate dopo il trasferimento in America, Dave Derby (Gramercy Arms ) e Joan Wasser, mentre la produzione di Chris Merrick Hughes garantisce il giusto equilibrio tra scenari sonori e residui cantautorali.
La potenza disarmante del disco è racchiusa negli abbondanti quattro minuti di “This Can’t Be Happening”: non solo la voce di Lloyd Cole è filtrata dal vocoder ma il testo è condensato in sole tre righe: "Non puoi crederci/ Non può essere possibile/ Ma sta succedendo adesso”. Una sintesi perfetta della colta evoluzione del crooner del Derbyshire. Dietro le quinte, si avverte una certa dedizione per un musicista che sembrava lontano dal mondo jangle-pop di Lloyd Cole, ovvero David Bowie, citato a spron battuto nell’eccellente “The Idiot” (notare il titolo, please) con particolare riferimento al periodo berlinese del Duca Bianco (“Ci trasferiremo a Berlino/ Smetteremo di essere tossicodipendenti/ Pedaleremo e nuoteremo”).
Anche la ruvida “Warm By The Fire” resta asservita a questo nuovo linguaggio sonoro, perfettamente incastonata tra la romantica e seducente title track e l’apocalittica digressione elettro-pop di “I Can Hear Everything”.
Non saranno pochi i fan che accuseranno il musicista inglese di aver tradito le geniali intuizioni jangle-pop degli esordi, ma a essere onesti queste otto canzoni rappresentano la giusta evoluzione di un cantautore che ha deciso di crescere e di assecondare la propria attitudine artistica. Un brano come “You Are Here Now”, con le sue tribolazioni elettroniche, rock e perfino ambient-minimal, è il giusto anello di congiunzione tra il presente e il sottovalutato ultimo capitolo con i Commotions Mainstream, e nonostante la veste elettronica “More Of What You Are” ha tutte le coordinate armoniche per essere una lost track del passato. L’ultima traccia “Wolves” scioglie qualsiasi dubbio: elaborata e concepita con una stratificazione di synth dall’ingannevole incedere ritmico, è una fantasiosa divagazione tra dream-pop e suggestioni da futuristico field recording, in cui echi kraut e timbriche alla Brian Eno si intrecciano, dando origine a un groove ipnotico e ricco di potenziali sviluppi creativi (non a caso, è stato progettato un set di remix che ha già coinvolto Barry Burns dei Mogwai, Martyn Ware e Chris Hughes).
On Pain è un disco temerario, senz’altro indigesto per i vecchi fan, ma la cosa buffa è che mai come in questo caso Lloyd Cole è riuscito a cogliere lo spirito avventuroso e innovativo di quell’era che gli regalò fama e successo.
Racchiuso nel suo accomodante microcosmo di influenze apertamente espresse, il Lloyd Cole recente sa farsi valere per una spontaneità comunicativa ritrovata e una scrittura di livello. Un piccolo bignami di una carriera affrontata con maggiore consapevolezza nei propri mezzi rispetto alle ultime uscite. Ma tutto sommato niente è mai cambiato: Lloyd scrive, ancora, semplicemente, musica per cuori infranti, tentando, con le sue ballate ironiche ed emozionanti, di lenire quella ferita sempre aperta nell’anima degli adolescenti di una volta che, tuttavia, non sono mai riusciti o non hanno mai voluto diventare adulti.
Contributi di Francesco Amoroso, Francesco Giordani, Andrea D’Addato, Mauro Caproni, Gianfranco Marmoro

Discografia
| LLOYD COLE AND THE COMMOTIONS | ||
| Rattlesnakes (Polydor, 1984) | 8 | |
| Easy Pieces (Polydor, 1985) | 6,5 | |
| Mainstream (Polydor, 1987) | 7 | |
| 1984-1989 (antologia, Polydor, 1989) | ||
| Lloyd Cole. The Commotions. The Singles (antologia, Polydor, 2004) | ||
| LLOYD COLE | ||
| Lloyd Cole (Polydor, 1990) | 6,5 | |
| Don’t Get Weird On Me Baby (Polydor, 1991) | 7 | |
| Bad Vibes (Polydor, 1993) | 6 | |
| Love Story (Polydor, 1995) | 6,5 | |
| Collection (antologia, Polydor, 1998) | ||
| Plastic Wood (Polydor, 2001) | 6 | |
| Etc. (antologia, Polydor, 2001) | ||
| 2001 - Collected Recordings by Lloyd Cole (antologia, Polydor, 2001) | ||
| Cleaning Out The Ashtrays (antologia, Polydor, 2009) | ||
| Radio Bremen: Folksinger Volume 1 (live, Polydor, 2009) | ||
| The Whelan: Folksinger Volume 2 (live, Polydor, 2009) | ||
| Music in A Foreign Language (Polydor, 2003) | 6 | |
| Antidepressant (Polydor, 2006) | 6,5 | |
| Broken Record (Polydor, 2010) | 5,5 | |
| Standards (Tapete Records, 2013) | 7 | |
| Guesswork (earMUSIC, 2019) | 7 | |
| On Pain(earMUSIC, 2023) | 7 | |
| THE NEGATIVES | ||
| The Negatives (XIII Bis Records, 2000) | 6 | |
| LLOYD COLE & HANS-JOACHIM ROEDELIUS | ||
| Selected Studies, Volume 1 (BureauB, 2013) | 6,5 |
Streaming
Perfect Skin | |
Forest Fire | |
Rattlesnakes | |
Perfect Blue | |
Cut Me Down | |
Lost Weekend | |
My Bag | |
Jennifer She Said | |
No Blue Skies | |
Period Piece |
Lloyd Cole su OndaRock
Recensioni






Lloyd Cole sul web
| Sito ufficiale | |
| Testi |






